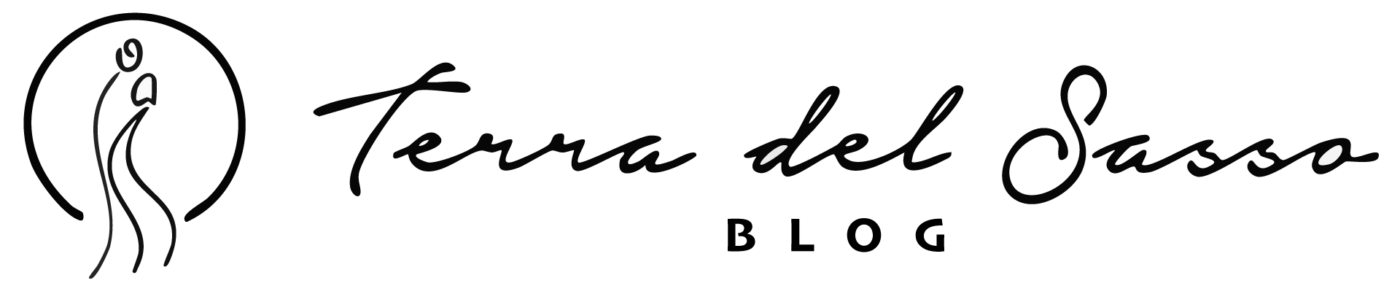Terra del Sasso
Oggi più che mai la nostra Terra merita di essere riscoperta e raccontata. Oggi, che i riflettori sul palcoscenico di Matera, Capitale europea della cultura, si sono spenti, ma resta molto alta l’attenzione dell’Italia e del mondo sulla nostra terra, sui nostri paesi, sui nostri paesaggi, sui nostri costumi, sulla nostra enogastronomia: in una parola, sulla nostra storia.
Questa attenzione non va delusa, non solo per ragioni di cortesia (o anche di vanità), ma perché concretamente può creare grandi opportunità di lavoro e di sviluppo che i nostri giovani possono cogliere, in un mondo globalizzato in cui le distanze si riducono, le barriere sono abbattute e la conoscenza viaggia veloce su mille canali.
Se ci pensate i nostri borghi, le nostre terre, le nostre strade sembrano (e sono) più vive se pensiamo a tutte le genti che di qui sono passate, si sono fermate, trasformando paesaggi e costumi, che noi ancora oggi viviamo. Il nostro cibo è più succulento se condito da millenni di storia; i nostri salami assumono un sapore unico, inconfondibile, se pensiamo che già i Lucani li producevano, trasformando i cinghiali allevati, ed i Romani furono ben felici di apprendere il sistema di rifornire gli eserciti di carne insaccata (cibo energetico, pronto e sicuro) e da allora se ne rifornirono dalla Lucania; il vino assume un retrogustomagico se lo scopriamo fatto con vitigni selezionati già nella Magna Grecia; e così via: ogni cosa diventa unica, irripetibile e dunque di pregio, se raccontata bene, con semplicità e con onestà, senza invenzioni o edulcorazioni. La semplicità dei nostri sistemi produttivi non è più arretratezza, ma garanzia di tracciabilità e, quindi, genuinità, così come la rarità dei nostri prodotti da scarsezza può trasformarsi in pregio.
Insomma, semplicemente e banalmente, la nostra storia è, oggi, la nostra ricchezza.
E dunque con tanta buona volontà e passione (e con una buona dose di temerarietà, se non vogliamo proprio chiamarla follia!) ci accingiamo a raccontare dalle pagine di questo blog alcuni frammenti della storia del nostro paese e della nostra regione, parlando (o meglio, quando è possibile, facendo raccontare direttamente ai protagonisti o a testimoni coevi, o a chi se ne è interessato più compiutamente in passato, con il linguaggio dell’epoca) di costumi, di cibo, di cronache, insomma della storia minore dei nostri luoghi.Sicuri, peraltro, di rendere un servizio importante alla costruzione della storia maggiore, se non altro, nel renderla meno noiosa, più comprensibile e, forse, più affascinante e più facilmente memorizzabile.
Siamo consapevoli di accingerci ad un lavoro immane, forse superiore alle nostre forze ed alle nostre stesse competenze, ma siamo fiduciosi di incontrare lungo questo difficile e lungo cammino altri folli entusiasti di questa bella e sfortunata terra che ci aiutino a proseguire o ne prendano il testimone.
Dovuto ufficio di vicendevole gratitudine è il ravvivar la memoria di coloro, da cui abbiamo noi medesimi ricevuto la vita: – sosteneva nel lontano 1640 Francesco Capecelatro nella Prefazione alla sua Historia della citta, e Regno di Napoli – nè per altro la natura ha innestato negli animi umani l’amor de’ padri verso i figliuoli, e la carità dei compatriotti verso la patria, salvo perché nella rimembranza dei posteri sopravvivessero i predecessori, e negli scritti del cittadini si perpetuassero le città. Il che fare conosco essere a me di speciale obbligazione…così potrà essere ardentissimo sprone a tutti coloro, che ci vivono, e che dopo noi nasceranno, di seguitar per le medesime vestigia il glorioso corso delle loro famose virtù… per rinnovellar la fama de nostri antichi, e per accendere col loro esempio gli animi de viventi all’acquisto di pari gloria.
Ci piacerebbe in principio di questa fatica poter testimoniare la nostra solidarietà ed il nostro sostegno, per quello che può servire, alla città di Venosa, vero fiore all’occhiello della nostra regione, per bellezza di monumenti e per ricchezza di storia e di uomini illustri, che si accinge ad una fiera battaglia con altre 42 città italiane per divenire capitale italiana della cultura per l’anno 2021.
Parleremo allora in queste nostre prime pagine di Quinto Orazio Flacco e del cibo del suo tempo e di quanto Orazio amasse i prodotti della sua terra e l’arte tutta lucana di utilizzarli.