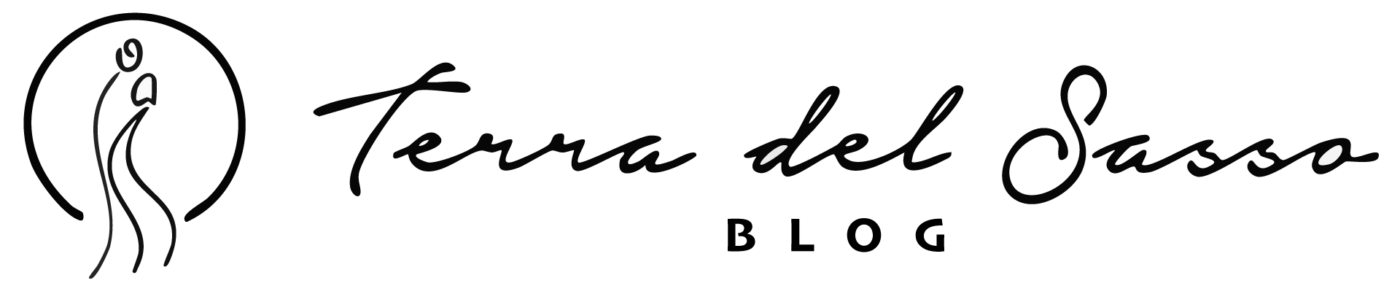Alcune testimonianze sulla vita a Sasso nel seicento
Vogliamo proporvi ora alcune testimonianze, rappresentate da apprezzi ed atti notarili, che danno un quadro della vita e delle relazioni sociali a Sasso lungo il corso del XVII secolo.
Storia minore!Si potrebbe dire.In realtà sono tasselli di un mosaico più grande della storia del Mezzogiorno d’Italia.
Proveremo a far parlare direttamente i documenti, così come sono rispuntati ai nostri occhi dai polverosi scaffali dell’Archivio di Stato di Napoli.
Consigliamo a tutti di leggerli con leggerezza, seppur con la sensibilità ed il rispetto che si deve alla voce della Storia, quando parla in prima persona.
Alcuni potranno trovare interessanti questi documenti, queste voci di storia minore, per supporto e conferma di proprie teorie sulla storia maggiore.
Altri, che hanno conoscenza dei luoghi, potranno ripercorrere quartieri e contrade della nostra terra, lasciandosi guidare da personaggi che sembreranno sorprendentemente vivi, in luoghi che la toponomastica consegnerà identici a quelli che noi conosciamo, seppur distanti diversi secoli.
Un prima testimonianza interessante la lasciamo raccontare al notaio Donato Margaglione, con leparole che lui stesso ha vergato in un atto pubblico del 1621.[1]
“Nel nome di Dio amen. Giorno 23 del mese di maggio 1621.Congregati e coadunati nella pubblica piazza della Terra del Sasso…Dominico Taurisano, sindico per il detto presente anno, Ascienzo De Oto, Leonardo Scielzo, Andrea De Tofalo, Tarquinio Cappa, eletti e deputati per la reggenza ed il governo della terra del Sasso, insieme ai sottoscritti altri uomini e persone della detta Terra congregati in pubblico Parlamento, ad onore e fedeltà del nostro Signor Re Filippo d’Austria, e per l’utilità ed il bene pubblico della detta Università, ove suole radunarsi per i pubblici affari, con licenza ed in presenza di Gio: Tommaso Nigro, Luogotenente di questa Terra, per ottenere il parere di ognuno come è nei costumi; avendo fatto più volte girare il bando nella persona di Leonardo (Zambrino?), Baiulo e Serviente della Curia di detta Terra, affinché ogni persona conferisse nella pubblica Piazza per fare il Parlamento, una volta adunati il sindaco e gli eletti in vulgari eloquio così si espressero:- Questa Università del Sasso retrovandosi debitrice in docati quattrocento et undici de moneta corrente alli figli et heredi del g.mo Cesare D’Ilaria della Salvia et per essi allo Ill.mo et Rev.mo Monsignore Fabrizio Caracciolo vescovo della città di Tropeia et sua diocesi per certo annuo censo comprato l’anni passati per il detto g.mo Cesare D’Ilaria da detta Università del Sasso come da pubblico istrumento appare et essendo passato il tempo di fare la satisfazione et il pagamento de detti docati quattrocento et undici, tanto de terze come di capitale, et non havendo detta Università altro modo de fare detta satisfazione et pagamento a detto Monsignore Fabrizio Caracciolo, per menor danno et intresso de detta Università, che vendere la decima di tutti vittuagli come sono grani, germani, orzi, lino, vino, frutti et allievi di ogni sorte de animali quatrupedi che si protesterranno et farranno per tutti li cittadini de detta Terra, et forastierihabitanti, et commoranti in essa, anzi per meno danno et più utile et expediente de detta Università vendere mezza decima, cio è decimando di ogni vinti una, et a questa ragione pagare alli decimatori, però in tutte le cose, franchi li franchi, et chi de ragione deve essere franco, et conforme alla capitulazione fatta per l’Università, et questo per spazio et tempo de uno anno da finirsi per tutto dicembre 1621, et che si habbia sopra de cio impetrare il Regio beneplacito et assenzo, et acciò ogni uno dica il suo parere si decideranno che si venda detta menza decima o no.[2]
All’atto è allegata una copia del regolamento stipulato dall’Università, sulle modalità e sui tempi di raccolta della decima, che costituisce un’utile fonte d’informazione sul valore di alcuni beni di consumo in quel lontano inizio del seicento a Sasso. [3]
“Capitoli fatti dalla Università del Sasso et per essa dal sindico et eletti del presente anno 1621 della menza decima da vendersi midiante lo Regio Assenzo de vinti una per pagare le terze a Monsignor Fabrizio Caracciolo come a successionario dello istrumento delli Ilaria per pagare docati quattro cento, et undici che deve detta Università.
In primis tutti i cittadini et habitanti in detta Terra del Sasso sono obbligati pagare fidelmente al decimatore la decima de tutti grani, germani, orzi, lino et vino in questo modo: de tutti li grani, pagato de tutto lo terraggio, censo, gabella che si deve al Barone, o alla chiesa, etiam le decime alli preti, ma quelli che si dovranno à patronali ne habia à pagare il patrone, de detti censi o terraggi accetto che fossero forastieri, ma che detta decima, de vinti una habia da pagare etiam quelli che siminasserofore termine.
Item che tutti li grani, orzi, germani, lino habiano dapassare per nante la ecclesia maggiore de detta terra et per avante lo monte avante l’Ecclesia de Santa Sofia al Casale [4] dove il decimatore possa annotare et pagarsi la rata che li tocca, de vinti una, et fraudando quello che frauda sia tenuto al doppio de quello che frauda al decimatore, et che li lini si habia da dare colati de aqua, de vinti una, ma che non si intenda lo scarto de detto lino, ne meno detto decimatore si li possa scegliere, ma che si li dia del misto come corre.[5] Et che il vino sia obligatolo decimatore hannarselo a pigliare dalla tina, però requisito dal patrone, et habia tempo tutto quello giorno della requisitionealtramente si lascia alla tina a risico del decimatore, et il decimatore non venendo al detto termine et acio il patrone si tenga la tina imbrattata, dove non potesse vindignare, et servirsi de detta tina sia lecito al patrone portarlo alle soi butte, et pagarlo al decimatore à ragione de grana vinticinque la salma [6] et detto pagamento habia tempo pagarlo per tutto lo mese de decembre, intendendosi de ogni vinti salme una al decimatore.
Item che possa il decimatore pigliarsi la decima de vinti una delli allievi, caso, recotte, lana, de pecore, bacche, crape, porci in questo modo: il botello à ragione de carlini venticinque l’uno, et aino et aina à ragione de carlini quattro l’uno, et lo capretto et capretta à ragione de carlini tre l’uno, et il porchetto et porchetta à ragione de carlini tre l’uno,[7] intendendosi però una volta l’anno la imporchia, etiam che allevassero doi volte l’anno, restando ad arbitrio de decimatore quando cape à potersi pigliare la rata che li tocca de ditto allievo, de vinti una, il quale pagamento si habia da fare l’ultimo de agosto prossimo.
Item per che la decima di caso, lana è fora di stagione per essere ormai finito l’anno universale de detta Università che per qualsivoglia pecora lattante si possa esigere de caso et recotta rotola doi, et la lana à ragione de uno quarto de rotolo per pecora, et ainomenzo quarto, et de capre lattante à ragione de rotola doi et menzo di caso et recotta per ciascheduna, che li tocchi al decimatore de ogni vinti rotola pigliarsi una.[8]
Item che il decimatore si possa esigere da tutte quelle persone che non arrivano alla somma de carlini dodici et menzo, vogliano pagare fino alla somma de detti carlini dodici etmenzo quelli che non arriveranno de frutti, intendendosi però quello che sta una onza allo apprezzo et li altri pagamento pro rata, che stanno notati allo apprezzo della testa tantum.
Item che detta decima si venda franchi li franchi.
Item che il decimatore habia da dare pregiaria de pagare all’Ill.mo Monsignore Fabrizio Caracciolo, o ad altra persona da esso deputata, farsi fare recevuta, senza lite o altro, ma siano per dinari exattia detto Ill.mo Monsignore per cassazione de detto debito, ma che detta pregiaria sia sopra la estinzione della candela, altremente si prenda a suo intresso.
Item che detto decimatore non possa vendere detti frutti di decima si prima non mostra havere pagato a detto Monsignore Fabrizio, o vero mostrare in scriptum licenzia de detto Ill.mo Monsignore o di altra persona in suo nome, ma si intendono sempre a quello obbligato a detto debbito.
Item non piacendo al sindico et eletti la posta de alcuni, sia lecito al detto sindico et eletti subito ammortare la candela, et non pigliare detta posta.
Item de detto fraudo non si ni possa fare querela ma pigliarsi il doppio de quello che frauda, et vada et sia del decimatore.
Item che detto decimatore li sia lecito volendo annare a notarsi la decima all’aira vi possa annare et che il patrone si li debia dare notizia a esso decimatore che per uno giorno de detta notizia debia annare detto decimatore, et non annandoci per uno giorno si le possano cacciare, et portarlo per li loci destinati come sopra.
Item che qualsivoglia pollitro et polletra somarina ni debia pagare a ragione de carlini vinticinque per uno cio è la decima di vinti una.[9]
Item che tutte quelle persone che fanno aluani ne debia pagare la decima et arrivando a decima ne debia pagare a ragione de carlini cinque per aluano.[10]
Item che tutti li soldati del Battaglione habiano a pagare la decima conforme pagarranno tutti li altri cittadini et così ancora li Sagenarij.
Item soccedendo Dio non voglia alcuna sciaura de Aria che facesse intresso alli vittuagli detto intresso si debia fare apprezzare da duihomini d’abene, et quello che determinerranno, quello contentarsi detta Università et anco il decimatore.
Item che detto decimatore non possa dimandare scomputi, ne mettere lite a detta Università, ne de assenti ne di non potenti ne per altre persone che petrennessero essere franchi, et che stanno con persone franche, ma che si le debia a suo peso, senza pigliare nesciuna lite con la Università.
Tomasi loc.te
Il segno della croce de Dominico Taurisano sindico
Il segno della croce de Ascienzo Doto eletto
Il segno della croce de Andrea De Tofalo eletto
Il segno della croce de LinardoScielzo eletto
Il segno della croce de Tarquinio Cappa eletto.
Per lo stesso anno vi proponiamo un ulteriore prezioso documento,[11] recuperato dall’Archivio Caracciolo di Brienza, insistente nell’Archivio di Stato di Napoli, che descrive, con dovizia di dettagli, la rendita che la Terra del Sasso procura al feudatario, fra diritti feudali ed entrate burgensatiche.[12]
“Intrate feudali della Terra del Sasso et come sono affittate in anno cominciato ad agosto 1620 et finite ad agosto 1621:[13]
– l’ Università del Sasso paga per la bagliva duc. 100
– la Mastrodattia della Corte affittata a Donato Antonio Arnone
di S. Angelo a Fasanella duc. 110
– la Portolania et danni dati affittata all’Università duc. 150
– la Taverna di dentro affittata a Gio: Batta Del Giurato duc. 10
– la Foresta di sotto la Terra affittata a particolari del Sasso duc. 60
– li renditi di diverse possessioni di particolari del Sasso duc. 74
– lorendito dello piano delle nuce duc. 2_2_19
– logiardiniello alle Carrare affittato all’arciprete duc. 1
– l’hortoallo Prato affittato a Giuliano Margaglione duc. 1
– altri renditi di diverse possessioni fatti l’anni passati duc. 2_2_7
– l’horto della Fontana affittato a Don Giulio Civita duc. 0_2
– altri renditi di particolari del Sasso fatti da Dominico Doto duc. 2_4
– l’aggiunzione della chiusa di Giulio Doto a Malandro duc. 0_3_2 ½
– l’aggiunzione della terra che fu di Lorenzio JacovazzoalliPuzzilli duc. 0_0_19
– l’aggiunzione dell’horto di Cicco RotundoalloFuosso duc. 0_0_3
– li renditi dellopartino di Gio: Perio Taurisano alloChiano la Preta duc. 0_1_0
– l’agionzionedellopartino di Gio: Persio Cammarota duc. 0_0_15
– un altro partino duc. 0_1_10
– lo censo della casa di Pomo di Pomo allo Casale duc. 0_2_10
– lorendito dell’horto di Ottaviano Romanza al Fuosso duc. 0_2_10
– lorendito dell’horto di Francesco Santoro al Fuosso duc. 0_0_15
– la scala di Geronimo Coronato avanti la sua casa alla Piazza duc. 0_0_5
– la difesa dello bosco a Tigliano territorio dello Sasso
dove l’Università ci ha il juslignandi comuni,
non si è venduta la ghianda quest’anno che non ha portato frutto
ma di bene l’erbaggio affittato a VincentioLopardo per boschi e difese duc. 17
– la Costara dove non si ci può tagliare arbori fruttiferi
come cerri, cerque, farghe et faghi
et quest’anno non s’è venduto perché non ha dato frutto
– la difesa seu bosco di Petridici trattando della parte imboscata
quasi tutta cerrina di sotto la strada pubblica che va a Marsico Nuovo
non s’è venduta perché non ha dato frutto. Fide in detta difesa
dove sono fidati di cittadini particolari di Marsico a legnare allo morto
perché non si può tagliare nulla sorte di arbori fruttiferi
come cerri, cerque, farghe et faghi
– la terra a Malandro che tene Potenzino Lancone duc. 0_1_4
– lo prato grande detto lo Prato della Corte, con arbori fruttiferi
come mele, pere, celsi et altri arbori dove se dice lo Fuosso,
fine la strada publica, li beni dell’arciprete Calcagno,
li beni di Gio: Jacovazzo et l’heredi di Marcantonio Calcagno,
20 grana si pagano con l’affitto di 250 ducati
che l’Università da per l’affitto della Portolania duc. 0_0_20
– lo pantano detto Pantano delle Pende fine la strada che va alla Costara
Entrate in grano
– un molino nello fiume di Malandro con il jusprohibendi e quest’anno sta affittato ad Urso Doto per tomoladucento settanta di grano buono et atto a ricevere dalla stessa molitura del molino
– la difesa del bosco di Petridici la parte coltivata quale sta sopra la strada publica che va a Marsiconuovolatieneno particolari del Sasso per tomola 209 e mezzo
– Giulio Doto per lorendito della chiusa a Malandro
– dippiù da tutto lo territorio demaniale Baronale… si esigge lo terraggio di queste terre che si seminano ogn’anno di ogni dieci tomola di vettovaglie tanto di grano, orgio, germano, leguma et di ogni altra sorte se nedanno uno tomolo alla Marchesal Corte, detta li terraggi
– e più consegna l’Università l’anno, lo tempo de la scognatomola 33 et un quarto et mezzo stoppello d’orgio alla Corte Marchesale, detto l’orgio della tassa
– et più possiede una vigna a Turri
– li prati dove si dice l’Acquara…che servono per comodità del signor Marchese
– la difesa della cerrina chiamata Fontana del Milo di tomola 200 incirca
– l’heredi di Vito Lancone deve per l’affitto delle terre al Raditiello tomolo 1 di orgio l’anno
– li prati alla Vardonica…5 tomola
– l’altra seminatoria dove si dice li Chiani Serrari sopra parte la strada che va a Marsiconuovo…tomola 6
– l’altra seminatoria dove si dice l’Aira di Petridici…tomola9 e 2stoppelli
– lo comprensorio della Cerasa…tomola 47
Entrate burgensatiche
– la casa di fabrica dove si dice la Via della Fontana, consistente in sette membri et stanze soprane e sottane che prima fu di notar Andrea Buonhomo, con l’orto contiguo…
– e più una casa terranea dove si dice la Macchia della Piazza…
– un horto dove si dice loFuosso…con molte piante di celsi…
– le chiuse e prati comprensorio di terra dove si dice chiuse della Canalecchia…di tomola 150 incirca con arbori…
– un pezzo di territorio dove si dice Ficetola di Verna di tomola30
– li prati dove si dice Pantano Via Chiana di 6 tomola con casalino
– un prato all’Hisca Cologna di tomola2 incirca
– una chiusa con piedi di cerri adHisca Cologna di tomola2
– prati et chiuse dell’Hischedel Molino che furnodelli Calcagni…tomola30
– una chiusa dove si dice il Macchitiello
– l’Hisca sopra lo molino di circa tomola2
– li prati alla Pantana
Il totale delle entrate feudali ammonta a 25423 ducati, a cui bisogna aggiungere 1192 ducati di rendite dai corpi burgensatici, per un totale di 26615 ducati, e in più l’obbligo per l’Università di “dare gratis al barone l’erario e due baglivi e lo conservatore, e di più lo panettiere che faccia pane per servizio di sua casa e di tutti li foresi di sue masserie…e ci può tenere da 2500 pecore franche, e senza pagamento niuno…e questo s’intende a tempo d’està”[14]
Il calcolo preciso viene fatto solo quattro anni più tardi dal Tavolario Federico Pinto, incaricato di valutare e quantificare i beni dei Caracciolo di Brienza, per gravi pendenze con il Regio Fisco.
Un cinquantennio di governo, tra il 1573 e il 1620, del Marchese Giambattista Caracciolo, condotto fra gli agi e lo sperpero smisurato [15], hannoportato le casse della camera marchesale di Brienza alla bancarotta [16]. Alla sua morte i figli Marcantonio, Giacomo e Giuseppe e la moglie Diana si ritrovano pieni di debiti, a cui non riescono a far fronte.
Il Regio Consiglio di Napoli interviene per sequestrarne i beni e dispone un apprezzo di tutte le proprietà, incaricandone il Tavolario Federico Pinto, che nel 1625 ne stila una relazione dettagliata, di cui in seguito riportiamo il titolo e la parte riguardante Sasso.[17]
…Siegue l’apprezzo della Terra dello Sasso, la quale sta due miglia distante da Brienza e da Pietrafesa quattro miglia, sta essa Terra esposta al Ponente, e viene riparata dallo Tramontano, l’abitazioni di questa Terra sono commode, e li suoi abitanti sono gente rustiche, attendono alla Coltura, e semina de campi, industriandosi alcuni di essi con qualche quantità d’animali pecorini, caprini, porci, et altri animali, fanno nelli loro Territorj grano bastante a loro uso, ma tengono molti Territorj seminatorj, et anco delli boscosi, tengono montagne di demanio, le quali sono abbondanti di pascolo et per molte parti di detto Territorio sono acque freschissime et in quantità, assai utili per la comodità di animali, li quali a tempo d’estate sogliono venire di fuori terra per la commodità di detti pascoli, et acque, siede, e stà situata questa predetta Terra in una grande altura di monte, edificate le sue abitazioni nella cima de sassi, così veramente sembra questo monte, è detta Terra d’airo assai sottile, e freddo d’inverno, e le donne che ivi nascono tengono buonissimo aspetto, e lo loro vestire è assai onesto, et in uno sollevato pizzo di Sassoso Monte vi sta lo Castello di detta Terra non più abile ad abitazione per essere la maggior parte di esso disfatto, però a tempo dello suo integro stato era sufficiente per la detenzione, e riparo d’abitanti a tempo di turbolenzie d’inimici, ci tiene il Signore in questa un’altra Casetta contenuta in tre stanze superiori, e di sotto stalla, ed altre Comodità. In questa predetta Terra sono più chiese, fra l’altre vi è la chiesa della Santissima Annunziata nella quale sono 8 preti di messa, e da 18 Diaconi, e se ci celebra giornalmente per l’obbligo che tengono, e vivono parte con beneficj, et entrate ecclesiastici, e parte dello proprio, e questo oltre delle messe votive, che dicono per divozione d’abitanti; vi sono ancora altre chiese, alle quali anco senci celebra, e per obligo, ed anco per divozione; sta questo predetto Clero sottoposto allo vescovo di Marsiconuovo, confina lo Territorio di questa Terra con lo Territorio di Brienza, lo Territorio di Pietrafesa, con lo Territorio di Marsiconuovo, lo Tito, Labriola, Vignola, e lo feudo di Satriano, si numera detta Terra essere di fuochi 151, secondo l’ultima numerazione; ed il Signore di essa ci possiede le subscritte entrate feudali, e burgensatiche…”[18].
Da una siffatta descrizione se ne ricava un’immagine di abbondanza e di benessere che suscita francamente qualche perplessità. Il territorio, ricco di pascoli e di acque, e la popolazione, che produce grano a sufficienza per il fabbisogno ed ha a disposizione un grosso demanio per raccogliere evidentemente legna e condurvi gli armenti,le donne che hanno buonissimo aspetto e vestono in modo assai onesto, il castello ormai diruto, ma testimone di antichi splendori: tutto lascia immaginare un quadretto un po’ bucolico, e comunque condizioni di vita discretamente buone.
Sicuramente vi è una buona dose di enfasi, ma potrebbe anche essere verosimile, per le considerazioni fatte precedentemente.
Le descrizioni dei secoli successivi risultano sicuramente più sconfortanti.
-
Archivio di Stato di Napoli. Sommaria. Consiglio collaterale. Provvisioni. Fascio 108, f. 327.Era sposato con Lucrezia Pepe. Nel 1630 nasce un figlio di nome Giuseppe (che ritroveremo protagonista della vita pubblica di Sasso per tutto l’arco del seicento), a cui fa da padrino Tesauro De Tesauro di Sicignano.Archivio parrocchiale di Sasso; registri di nascita. ↑
-
Naturalmente si dichiarano favorevoli tutti i civesparticulares interpellati: Potenzino Lancone, Antonio Coronato, Antonio Doto, Ottaviano Romanza, Dominico Santo Angelo, Titta (Giambattista) Perrone, Pepe De Pepe, Ferrante Lancone, LutioCammarota, Linardo Doto, Gianni Lo Giurato, Paulo Romanza, Gio: Dominico Lancone, Gio: Battista Santo Angelo, Orlando Lopardo, Giulio Perrone, Gio: Francisco De Vito, Francisco Sant’Oro, Giulio Carleo, Giulio Cammarota, Camillo Ciraso, Giulio Scielzo, Giulio Taurisano, Cipriano Doto, Giulio Rotundo, Gentile De Laurenza, Mario Margaglione, Lorito Civita, Lorito Lancone, Fabio Calcagno, Gio: Antonio Cappa, Gio: Linardo Taurisano, Alino De Marco, Pietro Rotundo, GoglielmoMargaglione, Antonio Lopardo, Angelo Doto, Cristiano Taurisano, Antonio De Vito, Pietro Gaito, Giulio Petrone, Francisco Doto. ↑
-
Archivio di Stato di Napoli. Sommaria. Consiglio collaterale. Provvisioni. Fascio 108, f. 327.Anche la copia, che riproponiamo integralmente così come scritta dal notaio Margaglione, è controfirmata dal Luogotenente, dal sindaco e dagli eletti. ↑
-
‘E la prima volta che si ha menzione di questa chiesa; verosimilmente sitratta della cappella poi intitolata a San Rocco, dopo la peste del 1656/7. ↑
-
Vi è dunque a Sasso, in quel lontano inizio del seicento, la tradizione consolidata non solo di coltivare il lino, ma anche di trattarlo e lavorarlo. ↑
-
salma s. f. [lat. tardo sagma, *sauma, dal gr. σάγμα «carico, basto»;3. Unità di misuradi capacità per aridi, usata in Italia e particolarmente in Sicilia, dove la salma legale equivaleva a circa 275,089 litri, prima dell’adozione del sistema metrico decimale; anche, unità di misura di superficie equivalente a circa 17.462 m2, nonché unità di peso usata nel sec. 16° per determinare la portata utile di una nave, equivalente a tre cantari (cioè, in Sicilia, a circa 238 kg).
Vocabolario Treccani.Da un rapido calcolo: se la ventesima parte di una salma di vino era costituita da 25 grana, il valore reale dell’epoca a Sasso era di 500 grana, cioè 50 carlini o 2 ducati e 1/2. ↑
-
Per lo stesso calcolo un vitello era pagato il quel lontano 1621 a Sasso 25 ducati, l’agnello 4 ducati, il capretto ed il maialino 3 ducati. ↑
-
Rotolo s. m. [dall’arabo raṭ]. – Antica unità di misura di massa e peso usata in Italia, e a Malta, prima dell’adozione del sistema metrico decimale, con valori diversi nelle varie città e regioni: 0,89 kg nell’Italia merid., 0,79 kg in Sicilia, 0,475 kg (peso sottile) a Genova, ecc.Vocabolario Treccani.L’unità di misura per il peso era,in quel tempo, a Sasso, il rotolo e corrispondeva a circa 890 g;in alcune località era pari a 3 libbre meno 3 once (circa 810 g). Cento rotoli formavano un cantaio, uguale a q. 0,890998, 20 rotoli formavano una pesa. ↑
-
Anche un puledro di somaro valeva dunque circa 25 ducati. ↑
-
Credo debba corrispondere ad Alano,variante di gualano (giovane dai dieci ai vent’anni che in alcune province dell’Italia merid. era allogato dai genitori come garzone di campagna per un esiguo compenso)Era dunque un lavoratore agricolo a contratto annuo, addetto alla custodia di terre o alla cura e al governo di animali (equini e bovini) che impiega nei lavori di trasporto o di aratura. Vocabolario Treccani. ↑
-
Archivio di Stato di Napoli. Archivio Caracciolo di Brienza. Busta 60. Platea dell’entrade feudali e burgensatiche delle terre di Brienza, Pietrafesa, Atena, Sasso e Sala per l’anno 1620. ↑
-
Le proprietà burgensatiche sono proprietà private, non appartenenti al feudo e, dunque non soggette alle leggi feudali. Ritroviamo descritte qui, grosso modo, le proprietà dei Caracciolo che, proprio perché burgensatiche, sfuggirono alla revisione della feudalità e poterono essere vendute, verso la metà dell’ottocento, ai Gaetani d’Aragona che si insediarono a Sasso non come feudatari, ma come proprietari di terreni e immobili. ↑
-
Era lo spazio di tempo di durata in carico di un’amministrazione comunale in quel tempo lontano.ilSindaco veniva eletto, per un anno, insieme agli altri amministratori, vale a dire il Capoeletto e gli altri 3 Eletti, che formavano una sorta di Giunta, dalla popolazione di Sasso riunita in pubblica piazza, nel giorno di ferragosto. Al Sindaco veniva consegnato il Libbronedei conti dell’Università ed il denaro eventualmente residuato dall’amministrazione precedente.Prendevano servizio dal primo settembre successivo e restavano in carico fino a tutto l’agosto successivo. Potevano essere rieletti solo una volta, poi per essere di nuovo eletti dovevano interrompere per almeno un anno. Al termine dell’anno amministrativo (vale a dire il ferragosto successivo) il sindaco e gli altri eletti dovevano rendere conto pubblicamente di tutti gli atti politici e, soprattutto economici, alla presenza di Razionali, figure simili agli attuali Revisori dei conti, che pure erano eletti in pubblico parlamento e non necessariamente appartenevano alla stessa Università.Nell’eventualità che i Razionali riscontrassero brogli o comunque ammanchi per cattiva amministrazione, il Sindaco e gli Eletti dovevano risarcire l’Università. Di questo, naturalmente, si teneva conto al momento dell’elezione, tant’è che potevano essere eletti solo coloro, anche analfabeti, in grado di garantire con proprietà eventuali risarcimenti. ↑
-
Archivio di Stato di Napoli. Archivio Caracciolo di Brienza. Busta 77,pl. 2 (1-33): Apprezzi – Istrumenti per crediti – Scritture diverse (1625-1775). ↑
-
In questo periodo furono acquistati dalla Casa di Brienza numerose proprietà a Sasso. In una sola occasione, dal 19 al 30 agosto 1609 risultano stipulati dal suddetto Marchese ben 17 atti con cittadini di Sasso per l’acquisto di chiuse, vigne, orti, ecc. nei dintorni del paese (Turri, Fosso, Cerasa, ecc.). Archivio di Stato di Napoli. Archivio Caracciolo di Brienza. Busta 82; pl. 2 (1-21) e pl. 5 (1-4). ↑
-
Così si pronuncia sulla figura di questo marchese, verso la fine del XVI secolo, un anonimo compilatore: “…Giambattista Caracciolo, Marchese di Brienza. Ha d’entrata ventunomila ducati gravati di debiti, che non gliene restano quattro da spendere. È uomo garbato, amico dello spendere, se n’avesse. Desidera novità. Dà recapiti ai fuorusciti e per tutti i segni non li piace il mondo come va. Sta continuo allo stato e sfoga la sua terribilità alla caccia”;Ceci G. I feudatari napoletani alla fine del secolo XVI, in “Archivio storico per le Province Napoletane”,anno XXIV, 1899, p 132. ↑
-
“Relazione ed apprezzo fatta dal Tavolario Pinto delle Terre di Brienza, Atena, Pietrafesa, e Sasso, e delli loro corpi, e rendite rispettive, come ancora di quelli si posseggono dall’illustre Casa di Brienza Caracciolo in pertinenza della Sala, e Vallo di DianoArchivio di Stato di Napoli. Archivio Caracciolo di Brienza. Busta 77,pl. 2 (1-33): Apprezzi – Istrumenti per crediti – Scritture diverse (1625-1775).Risulta l’unico superstite di ben quattro apprezzi e/o inventari che in quel decennio furono stilati sul feudo dei Caracciolo di Brienza, per controversie fiscali. Nell’anno 1623 Giacomo Caracciolo, che dopo la morte del fratello primogenito Marcantonio è diventato erede universale della casa Caracciolo di Brienza incarica di stilare un meticoloso inventario di tutti i possedimenti della casa marchesale di Brienza, che purtroppo è andato perduto. Come perduto è andato pure un altro inventario fatto fare da Marcantonio nel 1620, subito dopo la morte del padre Giambattista. Ed è andato perduto ancora un Apprezzo della Terra del Sasso fatto nel 1628 dal Tavolario Giordano. ↑
-
Nella descrizione dei confini si menziona il feudo di Satriano, residuo dell’antica città vescovile fatta distruggere due secoli prima dalla regina Giovanna, ancora separato da Pietrafesa e Tito, e non si parla del feudo dell’Arioso, anche questo residuo del grosso centro medievale Castel Glorioso, abitato fino al trecento inoltrato e poi abbandonato, incastonato fra Abriola, Vignola e Sasso, che troviamo descritto diverse volte in atti notarili fino alla fine del settecento. ↑