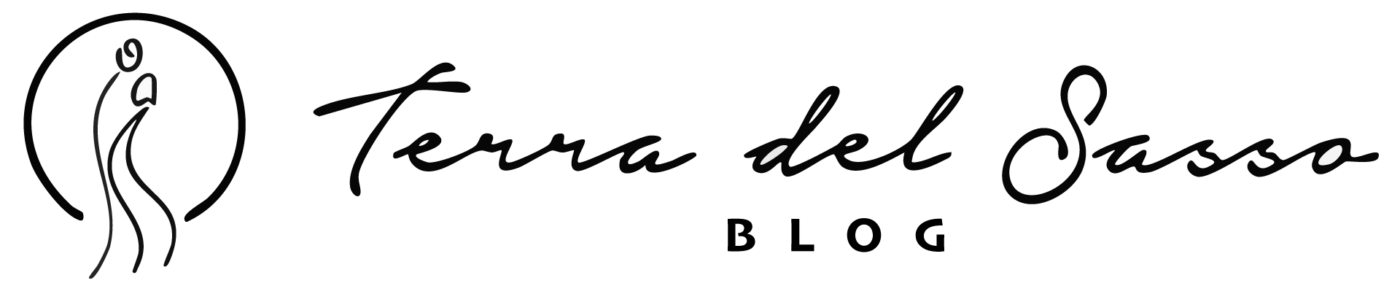1656
La peste che desolò Napoli nell’anno 1656
Riprendiamo il racconto di storie della nostra terra, ripartendo da una data non lontanissima dai nostri tempi e da un avvenimento terribile che martoriò le nostre popolazioni e desolò le nostre terre ed in particolar modo Napoli. Parleremo della grande peste del 1656 nel Regno di Napoli, o meglio, ce la faremo raccontare da chi se ne è occupato approfonditamente prima di noi e, dove è possibile, facendocela raccontare direttamente dai testimoni oculari.
Sono scene terrificanti e numeri impressionanti, quelli che ci si parano davanti agli occhi, che non abbiamo voluto descrivere nelle settimane precedenti, per non aggiungere angoscia a quella che già montava, per quello che stava accadendo intorno a noi, o che immaginavamo potesse accadere.
Oggi che sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel, è giusto dissipare la nebbia su momenti terribili che hanno vissuto in questi luoghi i nostri avi.
Partiamo da Napoli. Diremo un’altra volta cosa accadde nelle nostre contrade.

Domenico Gargiulo, Largo Mercatello durante la peste 1656
Museo Nazionale di San Martino, Naples
Nell’anno 1656 la città di Napoli e l’intero ex-Regno furono desolati da una fierisssima pestilenza, che fece inorridire i contemporanei, trasmise spaventose tradizioni,ed oggi non più trova fede in chi ha il coraggio di leggerne le relazioni sincrone. Non per la sola enormità di quell’orribile avvenimento, che pur sarebbe una ragione sufficiente a suscitare un legittimo desiderio di descriverlo: ma in nome dell’interesse sociale, e per ragioni superiori alla meraviglia, io mi sono determinato a narrarlo. Imperocchè questo fatto mi sembrava molto acconcio a dimostrare quanti danni derivano dal sacrificare i precetti dell’igiene al fanatismo improduttivo, e quanti pericoli sorgono da alcuni pregiudizi e dagli errori di una coscienza mal consigliata e debole. Così esordiva l’introduzione del Dr Salvatore De Renzi (medico napoletano della prima metà dell’ottocento, insigne infettivologo e storico della medicina) alla sua monumentale “Napoli nell’anno 1656”.
Io spero – si raccomanda poi – che questo racconto dia di quei tempi una esatta notizia, e faccia rilevare le cagioni che resero più grave quella sventura. Io mi rivolgo massimamente a coloro che seguono lo studio della medicina. I Medici assumono il grave mandato di tutelare gl’interessi della sanità degli uomini, e per loro sono grandemente istruttivi quei lugubri avvenimenti,che dimostrano con maggiore evidenza quali cagioni anche morali, anche derivanti dalla educazione de’ popoli, dalle condizioni civili,e da pregiudizi di ogni genere, possono spingere al sepolcro popolazioni testè fiorenti e numerose. E come eglino hanno l’obbligo di non risparmiare fatica per imparare a guarire le malattie, più ancora è loro dovere di guardare con maggiore curiosità e premura queste gravi vicende della vita, e profittare della scienza e più ancora della esperienza per dare utili consigli in pro delle popolazioni minacciate da influenze perniciose. Questa trista narrazione dimostrerà loro quali pericoli vengono dalla ignoranza e dai pregiudizii, e forse renderà più istruttiva questa storia, che riguarda tanto la medicina chela civiltà, tanto la nazione che la umanità intera.
Dalla ricostruzione fatta accuratamente dal De Renzi (ma condivisa da tutti gli storici dell’epoca e più recenti) la peste comparve a Napoli nelle prime settimane del 1656. Molto tempo dopo Milano (1629-1633) e tutto il resto d’Europa: le misure di controllo ai porti ed ai confini avevano funzionato fino ad allora perfettamente. Oltretutto da molto tempo erano stati preparati nuovi lazzaretti ed aree di eventuale quarantena, come risulta da documenti di oltre venticinque anni prima.
Ma quello che era stato costruito con sapienza e conservato con pazienza (nonostante le turbolenze della rivolta di Masaniello) fu travolto in breve dalle ragioni sorde della politica e delle armi: Milano (anch’essa, all’epoca, stato spagnolo) rischiava di essere perduta dagli spagnoli ed il vicereame di Napoli fu chiamato al soccorso. Arrivarono mercenari e soldati di ventura da ogni dove nel porto di Napoli, per essere arruolati e spediti in guerra in Lombardia.
Saltò, ovviamente, la cerniera sanitaria ed arrivò anche la peste, con dei mercenari provenienti dalla Sardegna; e si diffuse inizialmente nei quartieri intorno al porto, i quartieri popolani che avevano animato la rivolta di qualche anno prima.
E generale corse allora la voce – ricostruisce da testimonianze dell’epoca lo stesso De Renzi – che la peste nel1656 si fosse fatta venire dalla Sardegna a disegno per distruggere un popolo, che otto anni prima aveva fatto tremare la Spagna né ancora era interamente domato. Fu unanime la voce fra Napolitani culti, che fosse stato un vero assassinio. …Si faceva allora nel regno la numerazione delle famiglie, detta volgarmente la numerazione de’ fuochi, e gli Spagnuoli che in questo erano scrupolosi perché affar di finanza, cominciarono a rimaner sorpresi dal gran numero di morti subitanee che avvenivano nella plebe di un rione della città, detto Lavinaio, presso il Mercato o Foro Magno, teatro delle scene più tristi e più sanguinose della rivoluzione del 1647, e della tremenda reazione che ne seguì.
Il Viceré e la corte di nobili accondiscendenti ebbero tutto l’interesse (per sottrarsi alle responsabilità) a nascondere l’insorgere e la diffusione del contagio ed i predicatori di regime tuonarono sulla popolazione scossa ed impaurita, che si trattava non di peste, ma di una inevitabile punizione divina per il male che il popolo aveva procurato pochi anni prima. Mica per altro le morti si diffondevano nei quartieri più malfamati!
Un bravo e coraggioso medico (tal Giuseppe Bozzuto) denunciò fin dall’inizio la presenza della peste, riconoscendone caratteristiche cliniche e modalità di diffusione, ma fu imprigionato con l’accusa di diffondere notizie false e sediziose. Quando non si poté più negare l’evidenza (fu ufficialmente riconosciuta solo a metà maggio del 1656, dopo oltre quattro mesi dai primi casi denunciati dal Bozzuto), si diede la colpa (tanto per cambiare!) agli stranieri e cominciò la “caccia all’untore”, che diede origine ad episodi di ferocia inenarrabili. Una donna con un bambino in braccio, in abito straniero, sospettata di aver gettato delle polveri sulla frutta al mercato, fu aggredita, trascinata dalla folla inferocita, fatta a pezzi e gettata insieme al figlioletto, dal Ponte della Maddalena: uno degli episodi testimoniati dalle cronache dell’epoca.
E la peste (non riconosciuta e non isolata finché si poteva) intraprese la sua violentissima ed inarrestabile corsa.
« Nell’anno infaustissimo 1656 – riferisce Carlo Celano – la nostra povera città (ingannata dalla propria fidanza) fu assassinata da una fierissima pestilenza, che in soli sei mesi mietè, con orrori da non potersi scrivere se non da chi l’ha veduta (com’io), quattrocento cinquantaquattromila persone per lo computo che in quel tempo si potè fare alla grossa Non vi era più luogo da seppellire, né chi seppellisse: videro questi occhi miei questa strada di Toledo, dove io abitava, così lastricata di cadaveri, che qualche carrozza che andava a Palazzo non poteva camminare se non sopra carne battezzata ». La mortalità cresceva ogni giorno, per modo che si perdè ogni confidenza ed ogni disciplina. Cominciò il popolo a negarsi alle prescrizioni del Deputati di sanità, successe la confusione, e gli editti non furono più ubbiditi. Niuno voleva essere rimosso dalla propria casa, né voleva essere condotto al Lazzaretto.In tali momenti, spregiate le prescrizioni sanitarie ciascuno si diede alla fuga…ma le città tutte ed i villaggi del Regno erano severamente custoditi, e respingevano i fuggitivi…Nella città intanto continuava la strage…Si calcola che la mortalità giornaliera per la peste, in alcuni giorni del mese di Luglio, non sia stata minore di ventimila. S’arrivò finalmente al punto che cominciarono a mancare i mezzi per raccogliere e trasportare i cadaveri. Cumoli di cadaveri – ci testimonia, in un’opera di qualche anno dopo (1661), un altro testimone oculare, il Carmelitano Michelangelo Florio – tratti dalle case o dalle vie, e molti morenti o in deliquio eran portati in una enorme e cieca grotta, che si chiamava degli Sportiglioni, presso Poggio Reale, e si scrive che non meno di sessantamila ve ne fossero raccolti, ed alcuni portati da’ più cari parenti, i quali si affrettavano a gittare in quella voragine gli stessi figli, gli stessi genitori, contenti di potersi presto involare dall’orrendo spettacolo, e senza che per alcuno vi sia stato alcun segno di rito religioso.E spesso a tale era arrivato
il numero de’ cadaveri, che dopo aver ammassato su quei miseri carri quanti più era possibile, altri legati alle funi si trascinavano dietro a quei carri, e spesso mancato ogni mezzo di più trasportarne, si ammassavano a cataste, ed accese le pire si bruciavano.
Pur crebbe tanto la morte – continua il De Renzi – che ogni sforzo umano riuscì inutile. Spalancati i sepolcri nelle Chiese, spalancate le Chiese stesse, e riboccanti di cadaveri imputriditi, nel cuore di està, le piazze, le vie, gli orti vicini, le spiagge erano coverte di mucchi di cadaveri. Da una sola famiglia spesso erano portati alla sepoltura quattro o sei cadaveri: imperocchè non vi era casa senza lutto, massime ne’ mesi di giugno e di luglio, nei quali la strage fu così fiera, che non si era giammai veduta per lo passato in alcuna parte della terra. Che se in altre parti del mondo la peste aveva continuato per molti anni; in niuna parte come a Napoli aveva spento tante vite in minor tempo.
Laonde per non far rimanere i cadaveri insepolti, e liberar la città dal grave incomodo e pericolo del fetore della corruzione, il Vicerè promulgò la immunità a tutti coloro che erano chiusi negli ergastoli e nelle galee, non che a’ fuorbanditi, i quali insieme con gli schiavi turchi erano riabilitati alla società col solo obbligo di seppellire i cadaveri.
In preferenza morivan coloro che erano obbligati ad avvicinarsi agli appestati: dei Medici, de salassatori, de li parrochi, delle commissioni di sanità non ne scampò un solo, cosicché dovettero essere più volte rinnovati sul campo della fiera battaglia. Dei fanciulli non rimase alcuno, e delle donne pochissime scamparono. I conventi degli uomini furono quasi spopolati, ed una volta penetrata la peste, uccideva tutti;
da’ monisteri delle donne si salvò un numero maggiore, perché maggiore la custodia e più provvedute de’mezzi d’isolamento.
Un quarto dei trentanove Parrochi– riferisce, da testimone,lo storico Carlo Riaco, in una sua pubblicazione del 1658 – ed un quarto del canonici rimase superstite. De’Preti la peste involò ottomila. Nel Seminariodi Santa Maria di Loreto, in Santa Marta della colonna di S. Francesco, per calcolo diligentissimo elaborato, delle sei parti ne perirono cinque. Nella Pietà de’ Turchini trecento morirono tutti. Nelle Scorziate, Paparelle, Cappuccinelle quattrocento donne; gl’Incurabili e Convertite, altre quattrocento, di ogni nove morirono sette. …morirono dei nobili 5550; dei sei del Collaterale Consiglio ne morirono cinque; de’ tremila chiusi nelle carceri ne morirono duemila ed ottocento; de’ mercanti capi morirono trecento quaranta; de’ lavoranti duemila; dei medici quattrocento; de’ Chirurgi seicento; de’ farmacisti e giovini trecento trenta; de’barbieri e flebotomisti duemila e seicento; de’ pittori e loro allievi duecento venti; degli Scultori Intagliatori e Statuari ottocentonovanta ; degli Stampatori, Figurai ,Librai e famiglie mille quattrocento; dei gioiellieri orefici ed argentieri 1930; degli operai dell’ artedella seta 2990, etc.
Il De Renzi recupera un conteggio abbastanza meticoloso fatto dal Riaco in alcune Ottine e quartieri di Napoli, con lo scopo di conoscere quale era la loro popolazione innanzi la peste, e quanti abitanti vi rimasero dopo. Se avesse fatto questo calcolo per tutte le Ottine – puntualizza poi – avremmo potuto conoscere, almeno approssimativamente la popolazione di Napoli e la mortalità. Ma egli dimentica non meno di otto Ottine, importanti quasi tutte , come dimentica i villaggi e le borgate annesse alla Città. … E pure contentadoci di fare la semplice proporzione di queste otto Ottine solamente, si avrà per la città intera, escluse le ville ed i casali, ed anche quelli che formano essenzialmente parte della città (come l’Arenella, il Vomero, Posillipo, Fuorigrotta, Capodimonte, Miano, Marianella, etc.) si avrà la seguente proporzione:
Popolazione della città – 402000
Morti di peste – 313000
Superstiti – 89000
Ai quali, aggiunti la popolazione ed i morti delle ville e de’ Casali, la proporzione risale presso a poco a quella annunziata dagli Storici.Tutti gli altri storici anche contemporanei, e lo stesso Giannone, dicono che i morti non fossero stati meno di quattrocentomila, e questa sentenza è quasi generalmente adottata.