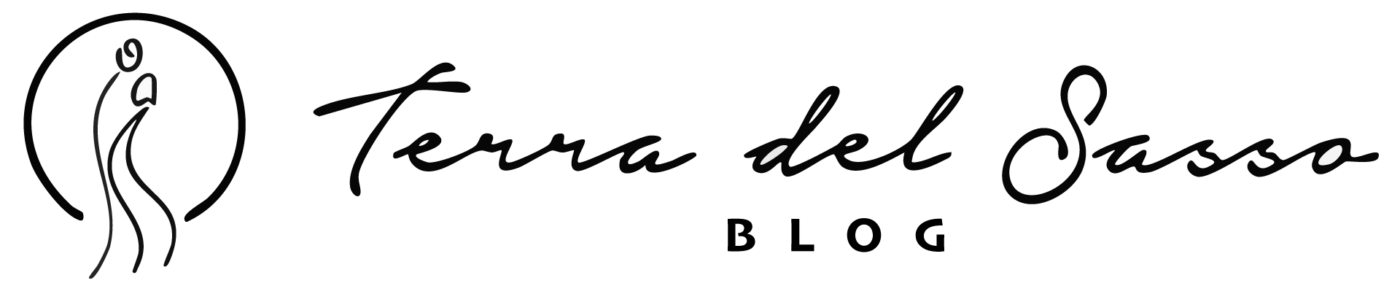Ancora a curiosare per la Terra del Sasso nel seicento

Non è difficile immaginare che la comunità della Terra del Sasso, in quel lontano XVII secolo, per quanto in espansione (demograficamente ed economicamente) e per quanto ricca di intelligenze e vivace socialmente, viveva una fragilità ed una precarietà estrema, poiché era pur sempre costretta in relazioni sociali rigide e oppressive, con un fisco spagnolo che sappiamo ancor più asfissiante dei regimi precedenti, a caricare ancor di più i pesi delle decime alla nobiltà ed al clero.
La Basilicata dall’Atlante del Magini. Bologna 1630.
Particolare della dorsale appenninica riguardante la nostra area.
Si può notare il confine amministrativo fra Basilicata e Principato Citra, con Brienza e Marsico Nuovo ubicate all’epoca in Principato Citra.Sono indicati i siti di alcuni antichi paesi non più abitati nemmeno all’epoca di questa cartina: Satriano e L’Aurioso ed alcuni siti riguardanti piccoli agglomerati rurali (Capo Venere, C. Margiotta, Pietraroggia) ed addirittura S. M. Pietrafaone con le sorgenti del Basento.
Un’economia così fragile che basta un episodio inconsueto per mandarla in crisi.
Già nel 1640 gli amministratori dell’Università si vedono costretti ad imporre alla comunità, ancora una volta, una gabella straordinaria, per far fronte ai pagamenti fiscali, dopo che l’alloggiamento di una compagnia di fanteria di 60 soldati per 40 giorni ha prosciugato interamente le casse comunali.
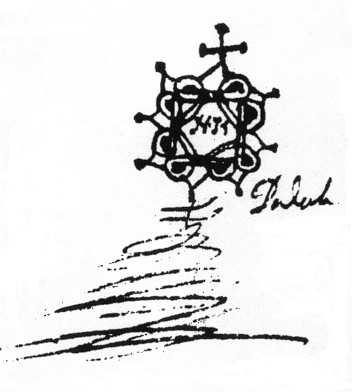
Così si rivolgono alla Regia Camera della Sommaria per chiedere il permesso di imporre questa tassa straordinaria: “l’Università et homini della Terra del Sasso fanno intendere all’E. V. come per spatio di quaranta giorni hanno tenuto d’alloggiamento una mità di Compagnia di Fantaria di numero sessanta dove hanno voluto per ogni giorno ducati dieci et in tutto vi sono corsi ducati quattrocento per lo quale alloggiamento la detta povera Università ne venne destrutta. Hoggidi veneno molestati e travagliati da diversi Commissari di pagamenti fiscali sette grana a foco, tarì (?) a foco, carlini vinti a foco et altre contribuzioni reali che in fare lo conto et in pagare tutte le sopradette partite alla Regia Corte teneriano di bisogno de docati ottocento et non hanno modo alcuno per quelle pagare ni per la penuria delli denari che come ni anco per non havere gabelle bastanti hanno fatto fra di loro revelatione mediante publico parlamento imponere nuove collette per questo anno tantum, sopra le bestiame de detta Terra de ogne diece una, cioè pecore, capre, porci et sopra l’animali baccine, giomentine, cavalline et somarine et possessioni delli particolari cittadini et habitanti in essa, et apprezzarli d’ogni cento docati apprezzati che saranno ne habbiano a pagare a detta Università docati dieci, et a rispetto di quelle persone che non teneno animali habbiano a pagare per ogni persona carlini dieci, che di tale modo detta Università potria venire a pagare detta Regia Corte per la summa ut supra et per non incorrere nelle pene contenute nelle Regie Prammatiche… chiedono quindi il beneplacito… ricordando che la Terra del Sasso è tassata per 100 focaggi”.
Alla richiesta di autorizzazione è allegato un atto del notaio Giovanni Padula che è il resoconto del pubblico parlamento tenuto a Sasso il 2 febbraio 1640, nel quale si sono prese queste sofferte decisioni.[1] L’atto ci chiarisce meglio come sono andate le cose. Gli amministratori probabilmente tentennano nel pagamento delle tasse (un po’ perché realmente le casse sono state prosciugate ed un po’ perché sperano di poter detrarre le spese sostenute per ospitare la truppa). Il Commissario per i pagamenti fiscali, allora, fa “una bona preda di pecore et capre di molti particolari et cittadini di detta Terra, le quale se l’ha portate nella Terra del Tito dove esso assiste et vendendosi detta preda saria una roina grande universale et particolare et per non venire a questi tormenti hanno fatto una resolutione di potere corrispondere se non in tutto almeno bona parte”. L’espediente escogitato dal Commissario risulta sicuramente efficace: in tutta fretta si nominano degli apprezzaturi[2] che, insieme agli amministratori (“senza aggravare nesciuno ma fare le cose giuste”), devono valutare la consistenza dei beni mobili dei cittadini, tanto il bestiame quanto le scorte in cereali (grano ed orzo) ed anche i denari a censo. Sembrerebbe che questa tassa straordinaria dovesse andare a gravare per intero sui possidenti, ma gli amministratori provvedono subito a chiarire: “quello che non have bestiame voglia pagare dieci carlini per persona”, si legge ancora nell’atto del notaio Padula.[3]
Logo del notaio Giovanni Padula
Tutto questo accade proprio mentre va in atto la farsa dei passaggi di proprietà della Terra del Sasso in seno alla famiglia Caracciolo e, subito dopo, l’altra della nascita del Ducato del Sasso, che abbiamo raccontato precedentemente.
Nel 1647 la popolazione di Sasso partecipa all’insurrezione antispagnola (la rivolta di Tommaso Aniello, passato poi alla storia come Masaniello), così come buona parte dei paesi della Basilicata e del vicino Principato Citra.
Naturalmente, più che un indirizzo politico preciso contro la dominazione spagnola, nei nostri territori assume piuttosto il carattere di rivolte e tumulti contro il potere baronale locale e gli immancabili loro sgherri.[4] Nella vicina Marsiconuovo viene fatto saltare in aria il palazzo di Don Francesco Pignatelli, signore della città, che intanto è riuscito a fuggire, ma vengono catturati e poi decapitati in piazza 14 uomini che hanno difeso la casa del Pignatelli.[5] Una descrizione un po’ più dettagliata di tali cruenti eventi ci è fornita da Mario Vignola nella sua recente, elegante ed interessante pubblicazione: “Dalla Città di Marsico Novo si ha – è il racconto che il Vignola riprende da un manoscritto giacente nell’Archivio Storico Diocesano di Potenza – che un capopolo di quelle terre con tutta la Plebe assediano il Palazzo di D. Francesco Pignatelli Signore di questa città e dopo molti rumori rotta la porta ed entrati dentro presero 14 uomini, che dal Pignatelli furono introdotti per custodia del palazzo, essendosi esso partito la notte per la volta di Roggiano, e condotti sulla Piazza fu a quei miseri tagliata la testa, e poscia con un barile di polvere fecero rovinare tutto il Palazzo,poi diedero fuoco a diverse case di Gabellotti ed affittatori de Dazi, ed essendo stato avvisato il capopolo che il Duca di Martina, con sua moglie, e comitiva di gente, dovea passare da novo per il territorio di Marsico determinano di assaltarli, e così unita una gran quantità di gente ed avviati alli confini di quella città, diedero sopra alla gente del Duca, e tra gli altri che vi morì fu il suo maggiordomo ‘a cui fecero la testa, il Duca si salvò con la fuga, e fu vano il pensiero del capopolo, poiché non potevano giunger quello, alla fine ritornati indietro ritrovarono molti muli carichi di monili, e particolarmente d’argent, quali furono da essi predati e trionfanti di questo ritornarono a Marsico”. [6]
Lo stesso Marchese di Brienza è costretto a fuggire.[7] Nella zona solo Marsicovetere, che appartiene ad un altro dei Caracciolo, resiste per un po’ di tempo alla furia popolare.
Nel gennaio del 1648 – scrive Rosario Villari – tutta la provincia di Basilicata ha aderito alla Repubblica ed i poteri effettivi sulla regione sono passati a Matteo Cristiano[8], che ufficialmente rappresenta, con la carica di governatore delle armi, il governo rivoluzionario di Napoli.
Sasso, come gli altri paesi del feudo dei Caracciolo di Brienza, viene additato dal Capecelatro come uno di quei Comuni che “durarono ostinatamente… nella loro perfidia”, anche quando ormai “si era racchettato tutto”.[9]
La ribellione ebbe però vita effimera; i capi (Matteo Cristiano e Francesco Salazar a livello regionale, il notaio Pessolani di Atena a livello locale) non ebbero l’opportunità ed il tempo materiale di applicare quelle riforme che pure avevano in programma e che probabilmente avrebbero consentito di compattare le varie forze sociali che avevano partecipato alla rivolta; così ovunque, a Napoli come in tutta la Basilicata ribelle, la rivoluzione di Masaniello fu stroncata nel sangue.[10]
Verso la fine di maggio del 1648 Giuseppe Caracciolo tornò nel suo feudo alla testa di quattrocento soldati, che gli erano stati autorizzati dal viceré per ridurre all’obbedienza le sue terre. “Il Principe di Atena – come abbiamo già riferito – ne gìo con buon numero degli Spagnoli datili dal Viceré ed altra gente da lui raccolta a porre in obbedienza Atena ed il Sasso, e Brienza e Pietrafesa del Marchese suo fratello, siccome rigorosamente fece, con dare aspro castigamento a coloro che avevano fallato”.[11] Nonostante avesse sottoscritto un manifesto con il quale la nobiltà si impegnava a non abbandonarsi a vendette e rappresaglie, per ben diciotto giorni tenne sotto il terrore i suoi vassalli. Ad un capitano preoccupato degli eccessi dei soldati contro la popolazione, avrebbe risposto: “lasciali morire e disshonorare a questi ribelli cani”.[12]
Tanto Giuseppe Caracciolo, Principe di Atena ed utile signore del Sasso, quanto suo fratello Giacomo, Marchese di Brienza ed utile signore di Pietrafesa, furono tra i più accaniti nemici della rivolta popolare ed avevano partecipato attivamente alla riorganizzazione delle forze baronali. Il Viceré Giovanni D’Austria scriveva nel luglio del 1648 a Filippo IV: “Don Giuseppe Caracciolo Principe di Atena è uno dei baroni principali di questo Regno, e tra quelli che con maggior efficacia hanno sostenuto in questi tempi di tumulto la causa di Vostra Maestà…e per questo motivo il popolo ribelle di questa città gli ha saccheggiato la casa… e tutti i suoi vassalli si sono ribellati”.[13] In un elenco dei “cavalieri che in questi tumulti, ritiratisi al Castel Nuovo, accudirono al Vicerè, perché resti di loro degna memoria…” vi è Giuseppe Caracciolo Rosso, Principe di Atena e suo fratello Giacomo.[14] Ed ancora in prima fila sono in un altro elenco del gennaio 1648 stilato sempre dal Capecelatro, di cui Giuseppe era intimo amico.[15]
Non appena rientrato il Principe in possesso dei suoi feudi, il 22 maggio 1648, e quindi, probabilmente ancora sotto il terrore dell’armata di soldati spagnoli che si era portato appresso da Napoli, il sindaco di Sasso Jo: Battista Lancone, gli eletti, fra cui il notaio Francesco Antonio Caso e altri, si recarono ad Atena, ove, davanti al notaio Cesare Puccino di Caggiano (che ne stipulò istrumento in pergamena), si impegnarono a pagare entro il settembre dello stesso anno a Don Giuseppe Caracciolo la somma di ducati 1443_16_1/3, come risarcimento per furto di vettovaglie[16].
Non sappiamo dove ed in che circostanza avvenne il furto di vettovaglie; se ai magazzini del vecchio castello, che Giulio Caracciolo un secolo prima aveva fatto restaurare, oppure al nuovo palazzo sulla strata[17] che Giambattista Caracciolo, dopo aver acquistato la casa del notaio Andrea Bonomo, aveva fatto restaurare ed ingrandire, con stalle e magazzini al pian terreno e dimora al primo piano. Non sappiamo se l’episodio (o gli episodi) si accompagnarono a violenza e spargimento di sangue. O piuttosto, non si trattò semplicemente di mancata corresponsione delle tasse e dei diritti feudali che i Caracciolo vantavano su Sasso.
Di sicuro si tratta di una cifra considerevole (di gran lunga superiore ai circa 1100 ducati annui che il feudatario percepiva dall’Università del Sasso in grano e denaro), che deve essere costata un bel po’ di pena e di fatica ai cittadini di Sasso.
Nonostante tutte queste vicissitudini e l’inclemenza degli uomini e della natura, la comunità della Terra del Sasso continua a crescere e prosperare.
L’attraversamento indenne della terribile peste del 1656/57 (che semina morte e distruzione in tutto il Regno di Napoli) rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e sviluppo per la comunità sassese, così come abbiamo riferito in altra occasione.
La dimostrazione tangibile di questo ci è testimoniata dalla prosperità e vivacità che il clero sassese attraversa in questo periodo.
Se nel 1614, come ci testimonia il vescovo di Marsico Timoteo Caselli, nel clero di Sasso partecipano 1 arciprete, 6 sacerdoti e 20 chierici,[18] già vent’anni dopo, nel 1635 (da una ricostruzione purtroppo parziale[19]), risulta così composto:
- Don Antonio Lancone – Arciprete
- Don Giulio Civita – Cantore
- Don Gregorio Civita
- Don Giovanni De Luca
- Don Antonio De Vita
- Don Antonio Doto
- Don Giulio Doto
- Don Marco Antonio (La) Padula
- Don Giovanni Lo Giurato
- Don Giovanni Margaglione
- Don Virgilio Rotundo
- Don Lonardo Sabbatella
La chiesa di Sasso, dunque, nei primi decenni del seicento, sotto la guida di Don Giovanni Battista Calcagno prima e di Don Antonio Lancone poi, ben supportata, nello spirito tridentino, dalla Curia di Marsico,[20] ebbe una crescita sensibile tanto economicamente quanto in autorevolezza e prestigio.
Nella relazione ad limina del 1659 del vescovo di Marsico Angelo Pinerio il clero risulta composto da un arciprete, un cantore, 14 sacerdoti, 16 chierici celibi ed uno coniugato. Il reddito ammonta a 100 ducati, 120 tomoli di grano ed altri emolumenti vari: viene diviso in parti uguali fra i sacerdoti, sono esclusi i chierici. La chiesa è dotata di organo (che invece mancava nel 1594) e vi sono anche delle sacre reliquie, decentemente custodite. Dalla stessa relazione risultano esservi a Sasso 6 chiese nel paese ed altre 7 fuori dal centro abitato [21]. Vi sono anche quattro Confraternite di laici[22]. Il vescovo Pinerio ha avuto modo di constatare che il popolo di Sasso, che ammonta ad 807 anime divise in 188 famiglie, è “docilis, et devotus, quia parocho diligenti regit” [23].
Il parroco diligente a cui fa riferimento il Vescovo di Marsico è l’arciprete Don Antonio Lancone, che si ritrova a dirigere la parrocchia di Sasso in un periodo davvero assai difficile per le nostre popolazioni: i moti del 1647, la terribile peste del 1656-57, i continui cambi di proprietà del feudo, ecc.
Nonostante ciò (o forse proprio per questo!) per la chiesa della Terra del Sasso rappresenta uno dei periodi di maggior fervore e di maggiore espansione economica: sono gli anni in cui (come testimoniato dagli strumenti citati nella Platea generale della chiesa del 1732), si realizzano numerosi contratti con l’Università (i fondi sono raccolti proprio dall’arciprete Lancone); sono gli anni in cui si realizzano numerose donazioni, che in parte sono donazioni spontanee di cittadini più o meno facoltosi (allo scopo di garantirsi messe perpetue per sé o per parenti defunti) ed in parte sono doti che le famiglie più facoltose della comunità portano alla chiesa per consentire a propri componenti di partecipare come sacerdoti alla mensa comune della parrocchia.[24]
L’espansione economica dovette essere davvero cospicua, se il clero sentì la necessità di redigere una nuova Platea dei beni della Chiesa di Sasso, la cui stesura fu affidata nel 1667 al sacerdote Don Carlo Scelzo, in qualità di Notaro Apostolico.
Questa Platea, così come del resto quella (o quelle) del secolo precedente, è andata perduta: viene riportata, citata come Platea antica, con buona dovizia di particolari, nella Platea redatta poi da Don Nicola Doti nel 1732.
Come si può rilevare anche dai dati forniti dal Colangelo [25], in questo periodo si verifica una grossa espansione del numero dei sacerdoti partecipanti e dei chierici, fino a superare le quaranta unità complessive e il 4% della popolazione totale.
Un fenomeno di siffatta portata, può essere solo in parte riconducibile ad un aumento delle vocazioni religiose.
Non poca importanza (come abbiamo già riferito altrove) devono aver avuto i privilegi che la chiesa era riuscita a strappare ai feudatari (specialmente in forma di agevolazioni fiscali sulle proprietà terriere e sulle piccole attività commerciali legate all’agricoltura), che finivano per riflettersi indirettamente anche su quelle famiglie che avevano la possibilità di inserire qualche proprio componente nella chiesa locale o, meglio ancora, nell’apparato diocesano.
Diamo di seguito una tabella riassuntiva della composizione del clero a Sasso per lo stesso periodo, ricavata dal Colangelo [26].
|
Anno |
1614 |
1659 |
1661 |
1664 |
1670 |
1675 |
1677 |
1681 |
1685 |
|
Clero Totale |
27 |
33 |
37 |
41 |
42 |
34 |
38 |
36 |
b) |
Arciprete |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Cantore |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Sacerdoti |
6 |
14 |
15 |
16 |
18 |
16 |
16 |
18 |
12 |
|
Diaconi |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
Suddiaconi |
1 |
||||||||
|
Chierici celibi |
20 |
16 |
19 |
22 |
20 |
15 |
20 |
20 |
b) |
|
Chierici coniugati |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
% sulla popolazione |
a) |
4,09 |
4,43 |
4,88 |
4,92 |
3,77 |
4,00 |
a) |
a) Non abbiamo i dati della popolazione per quest’anno.
b) Non sono riportati dati sui chierici.
Dai registri dell’Archivio parrocchiale e dagli atti del (contemporaneo) notaio Paolo Viscardi è possibile tentare una ricostruzione, parziale ovviamente, dei nominativi del clero di Sasso che per il 1661 sono:
- Don Antonio Lancone – Arciprete [27]
- Don Giulio (Cesare) Civita – Cantore [28]
- Don Angelo Taurisano – Vicario foraneo [29]
- Don Domenico Campiglia [30]
- Don Pietro Civita
- Don Giovanni Di Luca [31]
- Don Camillo Di Vito [32]
- Don Antonio Doto [33]
- Don Dominico Doto [34]
- Don Cesare Lo Giurato
- Don Giovanni Margaglione [35]
- Don Urso Oliveto
- Don Tommaso Pepe [36]
- Don Virgilio Rotundo [37]
- Don Linardo Sabbatella [38]
- Don Carlo Scelzo [39]
- Don Giovanni Battista Taurisano [40]
- Don Francesco Veruentano (Beneventano)
- Don Ascenzio Doto [41]
-
Archivio di Stato di Napoli. Sommaria. Consiglio collaterale. Provvisioni. Fascio 161, f. 43.. Previa licenza dell’Arciprete Lancone, per essere il giorno della presentazione della Madonna (gli atti pubblici non si potevano stilare nei giorni di festa) ed assenso e partecipazione del Luogotenente Gio: Tomasio Nigro, il sindaco Antoniello Petriello ed i quattro Eletti Antonio Veruentano (Beneventano), Giulio Rotundo, Gio: Berardino Sassano e lo stesso notaio Gioanne Padula fecero adunare ad voce di Conte Lancone, ordinario baglivo della Corte di detta Terra, i seguenti particolari cittadini…acciò ognuno dica il suo parere et intentione: Tullio di Luca, Ascentio Doto, Francesco Cappa, Buonhomo Pepe, Gio: Battista Lancone, Giuliano di Luca, Damiano Romanza, Gio: Camillo Doto, Gio: Linardo Taurisano, Francesco Margaglione, Gio: Francesco de Vito, Linardo Cammarota, Persio Cammarota, Gio: Linardo Gaito, Gregorio S. Angelo, Antonio de Vito, Andrea Scielzo, Alissandro Pepe, Francesco Antonio Mugnolo, Gio: Maria Jacovazzo, Vito Lancone, Taurisano de Taurisano, Loise Perrone, Antonio Rotundo, Gio: Battista del Giurato, Leone di Laurenza, Antonio Taurisano, Aurelio Scielzo, Angiolo Coronato, Alissandro Perrotta, Tomaso Lancone, Francesco Lancone, Felice Nigro, Cola Jacovazzo, Stefano Lancone, Giulio Lancone, Vicienzo Lopardo, Gio: Antonio Cappa, Lorito Civita et altri. ↑
-
Si tratta di Gio: Camillo Doto, Giuliano di Luca e Felice Nigro. ↑
-
Archivio di Stato di Napoli. Sommaria. Consiglio collaterale. Provvisioni. Fascio 161, f. 43. ↑
-
Successe anche in Potenza , che i popolari di essa Città, preso un tale appaltatore e riscuotitore di gabello, e quello a furore di popolo ignudo spogliat , e fattolo salassare nelle vene, girono uomini e e donne a succhiarne il sangue, e così il privarono crudelmente di vita. F. Capecelatro, Diario contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650, Napoli 1850-1854, vol. I, p 195. ↑
-
R. Villari, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, Bari 1977, p 115 (nota 11). ↑
-
M. Vignola. Marsico 1629 in once e regesti. Studio Elle. Marsiconuovo 2019, pp. 61-62 ↑
-
Sabato 31 di Agosto corse pericolo la Marchesa di Brienza, madre del Principe di Atena, avendo minacciato i popolari volerle bruciare la casa, onde le convenne passarsene prestamente alla Chiesa dei SS. Apostoli, e farvi condurre i suoi più ricchi arredi, con far venire altri popolari per ordine del Toraldo a custodire la casa; ma chiaritosi poi essersi racchetato il tutto, data certa poca moneta di mancia a coloro che l’ avevano custodita, in essa senza altro impaccio ritornò. F. Capecelatro, Diario contenente…, citato, vol. I, p 198. ↑
-
Straordinaria figura di patriota e di ribelle (purtroppo trascurata dalla storiografia ufficiale e pur anche da quella locale), Matteo Cristiano nacque nel 1616 a Castelgrande da Fabrizio, dottore in legge, e da Beatrice Polino, di Muro Lucano. Fu il principale artefice della rivolta antispagnola nelle provincie meridionali negli anni 1647/48. “Fra queste nobili figure, al certo può collocarsi il giovane dottore di legge Matteo Cristiano, che, ardente di parola e di azione, amante ed idolo del popolo, seppe eccitarlo ad imprese magnanime e moderarlo a suo beneplacito, unendo così alla audacia della insurrezione, la prudenza di animoso condottiere e quindi una eroica e gloriosa resistenza, nei rovesci della volubile fortuna”. A questo elogio patriottico si spinge il freddo magistrato N. Cianci Sanseverino, nel suo Un giudizio straordinario di crimenlese nel 1653 per i moti insurrezionali del 1647, presentato agli Atti dell’Accademia Pontaniana, XXIII (1893), pp. 10-22. Ed anche quando i moti insurrezionali furono spenti definitivamente l’intrepido Cristiano non si rassegnò alla sconfitta e non volle fuggire in lidi sicuri. Continuò senza tregua la sua battaglia contro la dominazione spagnola fra le montagne dell’Abruzzo, finché non fu catturato nell’agosto del 1653 e subito processato e condannato a morte. All’esecuzione fu data ampia pubblicità; – ci informa il Dizionario Biografico degli Italiani, V. 31. – i condannati furono condotti su tre carri al Mercato: era il 23 ag. 1653. Agli occhi della folla strabocchevole il Cristiano apparve alto, “d’aspetto civile”, ricciuto e rosso di capelli. Ottenne, per grazia speciale del viceré, di morire decapitato, anziché sulla forca. E ancora Nicola Cianci di Sanseverino, nella stessa relazione, ci consegna queste amare riflessioni: “Ed ora fo a me stesso l’augurio che, dopo l’oblivioso silenzio di due secoli e mezzo, si evochi, dalla oscura fossa, l’eroica figura del martire lucano, che alla giovine età di anni 31, lasciò gli agi e lo splendore di cospicua fortuna, i sudati trionfi del foro, e con coraggio, pari a quello degli eroi di Plutarco, scese armato in campo a sfidare e combattere animosamente, per ben 7 anni, la mala signoria di Spagna. La gloria e la vittoria vera dell’imprese sublimi ed onorate, è l’averle tentate. Ed il Cristiano veramente fu uno dei patrioti più insigni, per l’altezza dei pensieri e dell’animo… ond’è che,per il fuoco, l’audacia, l’impeto, la intrepidità, la costanza indomabile nelle deliberazioni e nelle azioni, ed infine per la grandezza della impresa, ha pochi pari e pochissimi superiori… Mancò al valore la gloria del trionfo, ma al certo non venne manco in lui, uno de’ primi e più grandi esempi, onde l’Italia, rigenerata e costituita a dignità di nazione, poté cancellare l’onta ed il danno del servaggio straniero”. ↑
-
F. Capecelatro, Diario contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650, Napoli 1850-1854, vol. IV, p 269. ↑
-
R. Villari, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna. citato, pp 116-126. Vedi anche G.A. Colangelo, La Diocesi di Marsico nei secoli XVI-XVIII, Roma 1978, pp 17-19. ↑
-
F. Capecelatro, Diario contenente…, citato, vol. IV, p 270. ↑
-
Villari R. Mezzogiorno e contadini nell’età moderna. citato, p 123. ↑
-
Villari R. Mezzogiorno e contadini nell’età moderna. citato, p 122 (n.31). ↑
-
F. Capecelatro, Diario contenente…, citato, vol. I, pp 233-234. ↑
-
F. Capecelatro, Diario contenente…, citato, vol. IV p 240. La casa Caracciolo di Brienza è legata alla rivoluzione di Masaniello anche per un curioso aneddoto raccontato da Michelangelo Schipa in uno scritto del 1916: un Masaniello ancora giovane, al servizio di un pescivendolo di casa Palermo, incontra tal Don Mercurio Cimmino, prete dello Stato Romano, maestro di casa della marchesa di Brienza e del Principe di Atena, suo figlio, che gli chiede di portare del pesce alla casa della marchesa; il giovane pescivendolo è talmente solerte e gentile che il sacerdote gli chiede di rifornire d’ora in poi sempre la casa Caracciolo e ne nasce una profonda amicizia; Don Mercurio Cimmino avrà modo in seguito anche di nutrire simpatia politica per Masaniello, tanto da trasformarsi in più di un’occasione in consigliere personale del capopopolo. M. A. Schipa, La cosiddetta Rivoluzione di Masaniello (da memorie contemporanee inedite); in Archivio Storico per le Province Napoletane. Anno 1916, parte I, pp 65-99. ↑
-
Archivio di Stato di Napoli. Archivio Caracciolo di Brienza. Busta 81.F. 4 (1-15): Crediti e liti contro l’Università di Sasso (1639-1807); f 2: perg. (1648, 22 maggio, Atena) – Istrumento per notar Cesare Puccino di Caggiano. ↑
-
L’attuale palazzo Gaetani in Via Roma. ↑
-
Marsicen. 26 novembre 1614: “…septima et ultima est Terra Saxi: habet ecclesiam sub invocatione Sanctissime Annunciationis in qua osservantur sanctissimum Eucharistie sacramentum et alea sacra. Habet fontem Baptesimalem. Habet sacristiam cum paramentis necessarijs, campanilem cum tribus campanis, pulpitum. Clero dicte ecclesie inserviunt Archipresbyter et sex sacerdotes viventes ex esiguis reditibus, et viginti clerici”. Relationes ad limina dei vescovi di Marsico: 1614 (Mons. Timoteo Caselli). ↑
-
La ricostruzione è stata possibile scorrendo i registri dell’Archivio Parrocchiale di Sasso ed alcuni atti dell’Archivio Caracciolo di Brienza. ↑
-
Lo stesso vescovo Caselli aveva disposto che tutti i parroci della diocesi, il 22 aprile di ogni anno,, in occasione della festa di San Giorgio, si dovessero recare a Marsico per relazionare sui problemi della propria parrocchia, in un atto formale di obbedienza al vescovo. ↑
-
Le 6 chiese nel centro abitato dovrebbero essere: la Chiesa Madre, la Cappella di San Giacomo, la Cappella del Monte dei Morti (o di S. Maria della neve), la Cappella di S. Nicola, la Cappella di S. Antonio e la Cappella di Santa Sofia (che proprio in quegli anni viene dedicata a S. Rocco; le Cappelle extra oppidum dovrebbero essere: quella dell’Annunziata, quella dei SS. Cosma e Damiano, quella di S. Vito, quella di S. Maria della Serra, quella del Carmine, quella del SS Salvatore e quella di S. Andrea (presso Pietra Castalda) o di S. Tommaso (nell’omonima contrada). ↑
-
Dovrebbe trattarsi di quella di S. Giacomo e dell’Annunziata, (che sono molto antiche), della Congrega del SS Rosario, di istituzione cinquecentesca (è attestata a Sasso già nella Relatione ad limina del 1594 del vescovo Fera: presbyteri deserviunt cum processionibus et anniversariis, ci rammenta R. M. Abbondanza nella sua Confraternite e luoghi Pii in Basilicata nell’età moderna, in Società e Religione in Basilicata/2-Collana studi storici, pp 14-15) e di quella del Monte dei Morti, che fu istituita qualche anno prima, al tempo del vescovo Ciantes. ↑
-
Relationes ad limina. Marsicen. Luglio 1659. Vescovo Angelo Pinerio. …Oppidus Saxi Marsico distat milliaris sex. Est sub ditione temporali eiusdem D. Faustine. Continet familias 188, Animas 807, adulti 615…Est in hoc oppido unica ecclesia parochialis tituli B. M. V. Annunciate que etiam receptitia est. Ministrant in ea Archipresbyter nuncupatus, Cantor, 14 Presbyteri recepti, 16 Clerici celibes et unicus Clericus coniugatus. Hi quotidie integrum divinum officium in ea ecclesia recitant. Missa vero conventuale celebrant in diebis festis et in festivibus B. M. Virg., missam defunctis qualibet feria 2°, et de B. Maria qualibet sabbato non impeditus iuxta rubricas. Redditus constitunt in duc. 100, ac 120 tumuli frumenti, et emolumentis incertis ex quibus componitur massa que annuatim dividit in capita, exclusis tamen clericis. Habet Concio in ea ecclesia tempore quadragesime. Adest organum et sacre Reliquie decenter asservate. Beneficia ecclesia personale rendita requirentium X. Ecclesia intra oppidum 6. Extra oppidum 7. Confraternitas laicorum 4. Clerus rudis est sed quo ad reliqua bene sogerit. Populus docilis, et devotus, quia a parocho diligenti regit. ↑
-
‘E interessante, a tal proposito, un atto notarile redatto, in data 6 agosto 1661, dal notaio Paolo Viscardi, in cui Giovanni Scelzo dona alla chiesa di Sasso “una vigna e un terreno arborato alla Preta” e “un’apoteca al Fuosso”, perché il figlio Vito Antonio possa ascendere all’ordine sacerdotale. Si legge ancora in questo rogito che la donazione è irrevocabile e potrà essere invalidata solo qualora Vito Antonio non diventasse sacerdote entro il venticinquesimo anno di età. Queste donazioni sarebbero andate a costituire una rendita perenne per la “Cappella del Glorioso San Giacomo”. ↑
-
G.A. Colangelo, La Diocesi di Marsico nei secoli XVI-XVIII, citato, pp 43-70. ↑
-
G.A. Colangelo, La Diocesi di Marsico nei secoli XVI-XVIII, citato, pp 46-48 e tavv 5-11. ↑
-
Muore all’età di 75 anni, il 9 novembre 1674, nella sua casa dietro la Chiesa Madre. ↑
-
Muore nel 1668. ↑
-
Don Angelo Taurisano passerà in seguito a svolgere funzioni nella Curia vescovile di Marsiconuovo. In un rogito del notaio Paolo Viscardi del 4 marzo 1675, ed in altri della stessa epoca, lo troviamo descritto come Annuario della Curia. Probabilmente lo è già dal 1672, perché in quell’epoca la sua funzione di Vicario Foraneo viene esercitata da Don Domenico Doto. In seguito sarà Arciprete della Chiesa di Sasso fino alla morte, avvenuta il 20 settembre 1683, all’età di 60 anni. ↑
-
Muore l’anno successivo, questo sacerdote dal cognome inconsueto, forse non di Sasso, ma documentato fra il clero di Sasso per tutto il decennio precedente e ricordato fra gli anniversari ancora il secolo dopo. ↑
-
Muore a 77 anni nel 1702, quindi è soltanto un omonimo dell’altro Don Giovanni Di Luca presente nell’elenco del 1635. ↑
-
Muore, a soli 37 anni, nel 1666. ↑
-
Muore, alla bella età di 90 anni, il 24 luglio 1679. ↑
-
Muore, a soli 52 anni, nel 1683. ↑
-
Cantore dalla morte di Don Giulio Civita, muore nel 1701. ↑
-
Muore nel 1682 ↑
-
Muore, alla bella età di 92 anni, nel 1692. ↑
-
Da non confondere con il Don Lonardo Sabbatella vissuto a Sasso circa un secolo prima. Muore il 12 marzo 1679, all’età di 75 anni. ↑
-
Muore, a 77 anni, nel 1692. ↑
-
Muore, a 57 anni, nel 1687. ↑
-
Proprio alla fine di quell’anno divenne sacerdote. Vi sono inoltre i Canonici Giovanni Coronato, Giovanni Felicito, Onofrio Margaglione. Il Diacono Don Giovanni Andrea Caso e il Canonico Tommaso Caso, figli entrambi del notaio Francesco Caso, esercitano le loro funzioni nella Cattedrale della Diocesi di Marsico. ↑